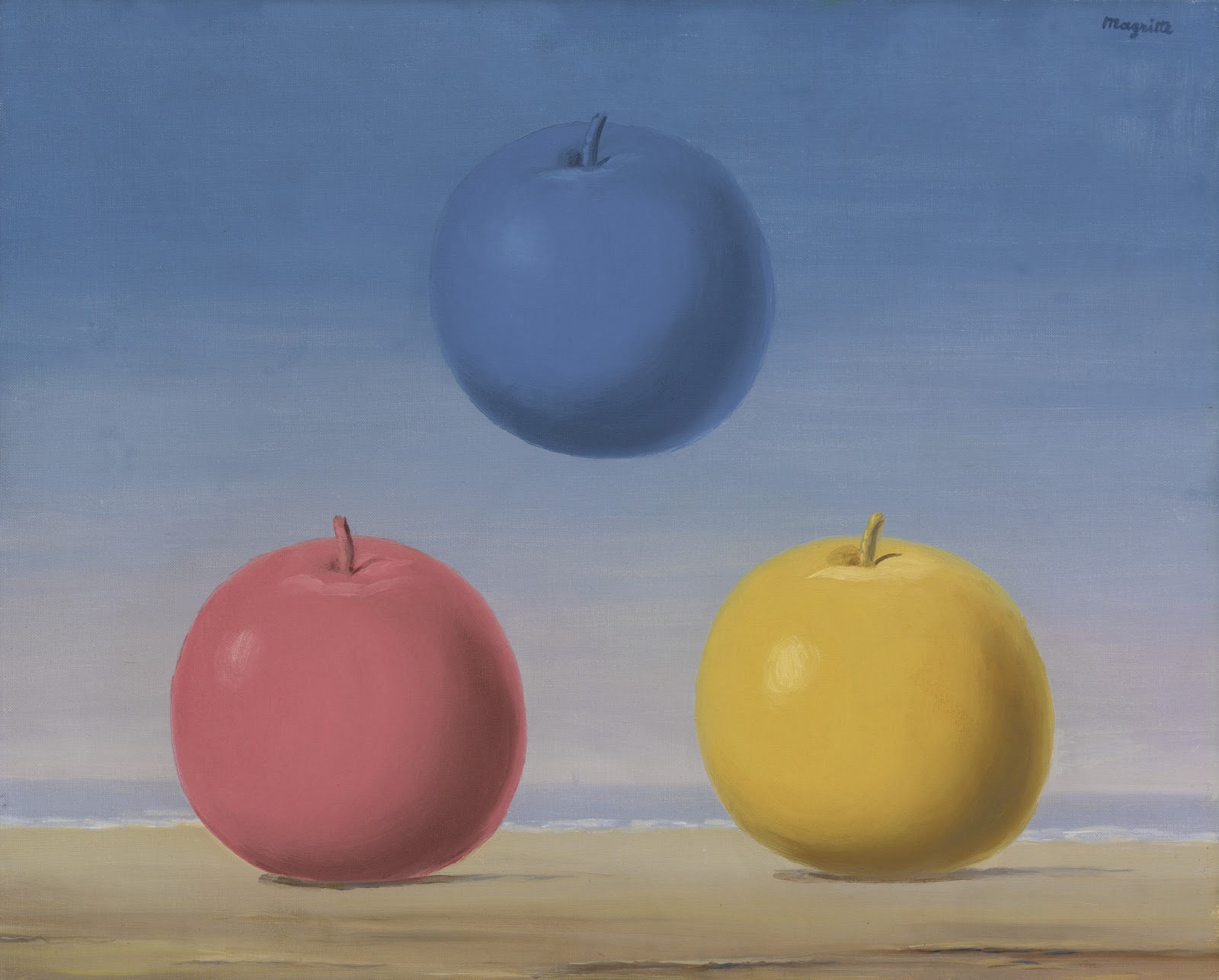La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che non vi sia il pericolo di trattamenti disumani nel caso della estradizione verso gli Stati Uniti della signora Beverly Ann McCallum, che aveva denunciato il rischio di essere assoggettata a pena perpetua senza possibilità di revisione.
I fatti. Beverly Ann McCallum, cittadina statunitense destinataria di un mandato di arresto internazionale emesso per i reati di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton (Stato del Michigan – U.S.A.) nel 2002, ricorreva alla Corte europea dei diritti dell’uomo invocando la violazione dell’art. 3 della CEDU (per una più completa ricostruzione dei fatti sia consentito rinviare ad un precedente contributo apparso su questo sito: L’art. 3 CEDU e il sistema di esecuzione penale statunitense in punto di ergastolo. In attesa della pronuncia della Grande Camera). La ricorrente difatti lamentava che, in caso estradizione nel Paese di origine, sarebbe stata inevitabilmente «vittima» di una condanna alla pena perpetua senza possibilità di liberazione anticipata.
I precedenti della giurisprudenza europea. Ciò in aperta violazione dei criteri cc.dd. Vinter. Con sentenza del 9 luglio 2013 (Corte eur. dir. uomo 9 luglio 2013, ric. n. 3896/2010. La pronuncia Vinter e altri c. Regno unito ha costituito la base per tutte le successive pronunce in punto di cd. right to hope, inclusa Corte eur. dir. uomo 13 giugno 2019, Viola c. Italia), la Grand Chambre aveva infatti precisato che il carcere a vita senza alcuna possibilità di rilascio («life imprisonment without parole») costituiva di per sé una violazione del citato articolo 3.
La decisione Vinter ha avuto importanti ripercussioni in molti casi successivi, primo tra tutti Trabelsi c. Belgio (Corte eur. dir. uomo, sez. V, 4 settembre 2014, ric. n. 140/2010). La Corte ha ritenuto la violazione dell’articolo citato nell’ipotesi di estradizione del ricorrente in uno Stato in cui si sarebbe probabilmente visto infliggere la pena del carcere a vita.
La ratio decidendi della pronuncia va rintracciata nel fatto che non solo il carcere a vita, ma anche il rischio di esservi sottoposto ricade nella definizione di trattamento degradante e inumano. Ogni stato firmatario deve essere in grado di assicurare una concreta possibilità di modificare le condizioni degli ergastolani a fronte di un serio ravvedimento.
Così facendo la Corte EDU ha mostrato di enfatizzare la sua adesione agli ideali di riabilitazione e reintegrazione dei detenuti. Del resto appare difficile comprendere come il carcere a vita, escludendo irreversibilmente l’individuo dal contesto civile e condannandolo di fatto «alla morte sociale», possa contribuire a determinare un serio ravvedimento del recluso. Gli Stati pertanto venivano chiamati a introdurre programmi di reinserimento anche per i condannati all’ergastolo, in modo da rendere comunque possibile l’eventualità della loro reintegrazione nella società.
Le odierne prese di posizione dei giudici di Strasburgo: una marcia indietro sulla strada della protezione dell’estradando contro il pericolo di trattamenti inumani. Il principio espresso da ultimo dalla Grande Camera nella pronuncia McCallum risulta di significativo impatto in quanto perimetra, o meglio ri-perimetra, l’ambito di applicazione del sopracitato articolo 3 in ambito estradizionale.
La Corte, anzitutto, ha cura di specificare che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, specie dal caso Trabelsi c. Belgio, sono ricavabili due diversi ordini di obblighi. Anzitutto un obbligo materiale imposto agli Stati di vigilare affinché una pena all’ergastolo non si traduca in una pena perpetua, e dunque, incompatibile con il più volte citato articolo 3. In secondo luogo importanti obblighi procedurali (sia pure solo in parte definiti da una diversa, seppur coeva, decisione. Il riferimento è alla sentenza Sanchez-Sanchez v. Regno Unito, Corte eur. dir. uomo 21 settembre 2022, ric. n. 22854/2020). A detti obblighi procedurali però – precisa la Corte nel caso McCallum- deve riconoscersi un’applicazione limitata esclusivamente agli Stati firmatari la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Non sarebbero invece traslabili all’ambito estradizionale perché – e questo è il punto chiave della pronuncia – in caso contrario “la responsabilità degli Stati contraenti sarebbe interpretata in senso troppo ampio”. Pertanto, per quello che è di nostro interesse in relazione alla decisione in commento, i richiamati obblighi procedurali non sarebbero estendibili agli Stati Uniti.
Ma vi è di più. La Grande Camera aggiunge che nel contesto estradizionale la verifica dell’applicazione dei principi sopra richiamati debba essere condotta in due diversi momenti cronologicamente successivi. Anzitutto grava sul ricorrente l’onere probatorio circa la sussistenza di serie ragioni per le quali, in caso di condanna, gli sarebbe inflitta una pena perpetua senza possibilità di revisione della stessa. Solo qualora l’esito di tale indagine sia positiva – continua la Corte – occorre verificare se nello Stato di destinazione esista un meccanismo che consenta alle autorità nazionali di esaminare nel tempo se vengano meno le basi giustificatrici della pena inflitta. Quanto alle le garanzie procedurali, invece, prosegue la Corte, la loro presenza “non è una condizione indispensabile per il rispetto dell’art. 3 da parte dello Stato contraente richiesto”.
La Grande Camera però, nella già citata decisione Sanchez (par. 99), avverte l’esigenza di precisare che la tutela sancita all’art. 3 CEDU rimane assoluta e che non sussiste alcuna differenza nel livello minimo di gravità che rileva nel contesto interno per l’attivazione della tutela e quello richiesto in sede di procedimento di estradizione.
A fronte di quello che sembra essere un vero e proprio revirement giurisprudenziale ad opera della Corte europea dei diritti dell’uomo, da più parti, si «denuncia», il pericolo che la garanzia convenzionale rischi di divenire un simulacro privo di effettività.
Di seguito il link con il testo della sentenza:
A cura di Giulia Vagli.