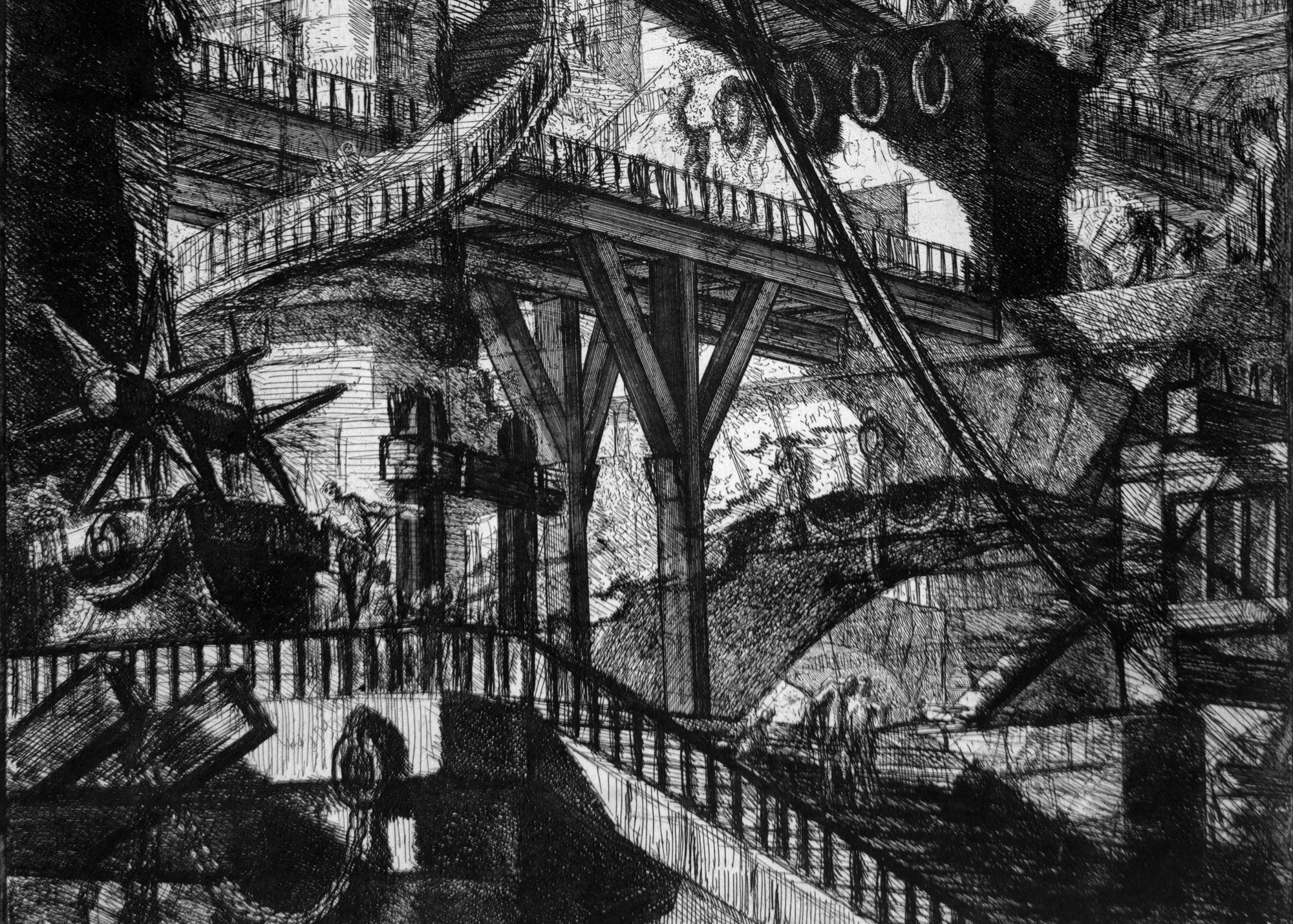1) Dal recente rapporto tematico del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale emerge con chiarezza un aspetto – fra gli altri – che merita di essere approfondito, ovverosia quello relativo alla <<persistente volontà dell’Amministrazione penitenziaria di ricorrere contro ogni accoglimento da parte della Magistratura di sorveglianza>>, anche quando – aggiunge il Garante – <<si tratti di questioni su cui già la Corte costituzionale si sia pronunciata>>. (v. pag.16)
Alludiamo, dunque, non solo alla mancata attuazione degli ordini impartiti dal magistrato con l’ordinanza che accoglie il reclamo proposto da un detenuto sottoposto al “carcere duro” (1), ma anche alla sistematica proposizione da parte dell’Amministrazione penitenziaria di reclami avverso tali ordinanze che, di fatto, costituiscono un grave ostacolo al necessario adeguamento alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e finisce dunque per compromettere l’effettività del reclamo giurisdizionale.
In proposito, è noto che alcuni profili della disciplina contenuta nello stesso art. 41 bis o.p. sono stati dichiarati incostituzionali. In tal senso ricordiamo, innanzitutto, la sentenza n. 186/2018 della Corte Costituzionale che dichiarò l’illegittimità costituzionale del divieto di cottura dei cibi, disposto dal comma 2-quater, lett. F, dell’articolo in parola. Di conseguenza – segnala il Garante – <<si apre l’interrogativo sul perché ancora sia previsto un modello 72, in quasi tutti gli Istituti, che non prevede generi alimentari da poter cuocere>> (v. pag. 16 ). Aggiungiamo, altresì, che secondo quanto previsto dall’art. 20 (ricezione pacchi) della circolare D.A.P. 3676/6126 del 2/10/17, i pacchi ordinari mensili possono contenere solo generi alimentari che non richiedano cottura.
Ed ancora, segnaliamo che la Consulta dichiarò l’illegittimità costituzionale anche del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità. Di conseguenza, non è ben chiaro – rileva il Garante – il motivo per cui lo scambio debba essere preceduto da una <<domandina>> e dalla <<compilazione ottocentesca di ingialliti registri>> (v. pag. 16), risultando in netto contrasto l’art. 3 (Inserimento del detenuto/internato nelle sezioni dedicate) della circolare laddove prescrive che «dovrà essere assicurata l’impossibilità di comunicare e di scambiare oggetti tra tutti i detenuti/internati anche appartenenti allo stesso gruppo di socialità».
Inoltre, per quanto riguarda la Corte di Cassazione, segnaliamo l’orientamento secondo il quale sono
<<illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d’istituto che (…) limitano ad una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all’aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. F) del comma 2-quater dell’art. 41-bis, all’interno delle sale destinate alla socialità>> (Corte di Cassazione, sentenza n. 17580 del 2019). Il riferimento, nello specifico, è all’art 11 (attività in comune), secondo cui i detenuti/internati possono permanere fuori dalle stanze detentive <<per non più di due ore al giorno da trascorrere all’aria aperta o svolgendo attività ricreative/sportive>>. Dunque, la formulazione letterale di questa disposizione pone nei termini di alternatività ciò che dovrebbe, invece, essere garantito contestualmente: la permanenza all’aria aperta e l’ora di socialità. Difatti, non seguono la stessa ratio e, come segnalato dalla Cassazione nella citata sentenza, devono essere tenute distinte, in quanto <<preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati>>. Infine, ricordiamo che tale orientamento, è stato preceduto da altre sentenze (Cass. n. 40761/2018; Cass. n. 48860/2018; Cass. n. 44609/2018), ed anche da ultimo confermato (Cass. n. 6358/2023).
2) Tanto premesso, il Garante prende in considerazione una lettera circolare dell’Amministrazione volta adeguamento al contenuto delle pronunce dalla Consulta e della Suprema Corte, emanata dal Direttore generale (facente funzioni) per i detenuti e il trattamento. Si tratta, nello specifico, della circolare prot. 132095 del 7 settembre 2020, m_dgGDAP 0338310.U del 29.09.2020, con la quale il Direttore generale dell’epoca, dopo aver elencato le questioni risolte dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione rispetto alle quali evidenziava un mancato adeguamento, <<ordina[va] al Servizio Reclami Giurisdizionali di non predisporre più reclami avverso le ordinanze emesse dai Magistrati e di non predisporre memorie per l’Avvocatura dello Stato volte alla presentazione dei ricorsi per cassazione avverso le ordinanze dei Tribunali>>. Al contempo, invitava i direttori degli istituti penitenziari a <<conformare l’azione amministrativa di loro spettanza ai principi ed all’interpretazione dell’ordinamento appena esposta>>. Tuttavia, lo stesso Garante segnala che l’anzidetta circolare fu dichiarata, a sole 24 ore di distanza, revocata <<fino a nuove eventuali disposizioni>> con la circolare m_dgGDAP 341745.U del 01.10.2020 predisposta dall’allora Capo del D.A.P.
La questione rimase, dunque, “congelata” per circa un anno.
L’Amministrazione ha provato, infine, a porre termine alla questione con la circolare m_dgGDAP 278339.U del 23.07.2021, intitolata Disposizioni in materia di esecutività delle ordinanze emesse dalla Magistratura di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. Tale circolare chiarisce, innanzitutto, la questione legata all’esecutività delle ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza. Difatti, dopo aver dato atto di aver investito della questione l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, nella circolare viene riprodotto il testo dell’autorevole parere, in forza del quale si deve ritenere che <<mai possa esimersi dalla immediata esecuzione di tutte le ordinanze emesse dalla Magistratura di Sorveglianza, ivi comprese quelle emanate in primo grado dagli Uffici di Sorveglianza in composizione monocratica, posto che l’eventuale rinvio della esecuzione “ben potrebbe portare alla frustrazione della ragione stessa del reclamo, considerando che per attivare la tutela è necessario che ricorra un pregiudizio, oltre che grave, anche attuale”>>.
Di conseguenza, sono state date alcune indicazioni di carattere generale, che possiamo sintetizzare nei seguenti punti: sulle Direzioni degli istituti penitenziari grava l’obbligo di dare informazione in maniera sistematica ai competenti <<Superiori Uffici>> circa le ordinanze emesse in primo e secondo grado nella materia de qua dai Magistrati e dai Tribunali di Sorveglianza. Sarà poi compito dei <<Superiori Uffici>> comunicare alle Direzioni l’avvenuta, o meno, impugnazione delle ordinanze, eventualmente accompagnata dall’istanza di sospensione ex Art. 666 co. 7 c.p.p.
Un siffatto meccanismo avrebbe dovuto nei fatti garantire una maggiore effettiva e immediata attuazione, tuttavia, al contrario, non ha avuto un riscontro generalizzato e, anzi, come segnalato dallo stesso Garante: <<ha trovato una disomogenea applicazione, (…) finendo con determinare nei fatti una problematica disomogeneità del regime nei diversi Istituti, con riflessi sulla serenità all’interno delle sezioni stesse. Ne è testimonianza l’alto numero di segnalazioni di non attuazione di quanto previsto dall’ordinanza del magistrato di sorveglianza, pervenute al Garante nazionale, anche successivamente a tale lettera circolare>>. (v. pag. 16) Dunque, viceversa, l’Amministrazione dovrebbe assumere un comportamento collaborativo, conformandosi alle statuizioni giurisdizionali ed evitando, invece, <<comportamenti dilatori o, peggio, elusivi>>. (2)
3) Volendo svolgere delle brevi considerazioni, rileviamo che un tale modo di procedere acuisca una criticità propria del reclamo giurisdizionale, legata per l’appunto, all’effettività – o ineffettività sostanziale – dello stesso. Difatti, se già sul piano teorico la presenza del “doppio grado di merito” rallenta la formazione del giudicato, presupposto indefettibile ai fini dell’esperimento del giudizio di ottemperanza, sul piano pratico, parimenti, viene di fatto rimesso all’Amministrazione la scelta su cosa meriti, o meno, un’immediata esecuzione, nonostante questa debba essere garantita a tutti i reclami accolti dalla magistratura di sorveglianza.
Paradossale, in tal senso, che la stessa Amministrazione richieda un chiarimento, dalla stessa definito come “autorevole”, salvo poi disattenderlo e diramare delle indicazioni volte alla cernita delle ordinanze meritevoli di immediata esecuzione. D’altronde, se il reclamo in parola rappresenta una tutela preventiva, nonché, inibitoria, finalizzata alla rimozione di un pregiudizio grave ed attuale della sfera giuridica del detenuto – specie se sottoposto al regime differenziato – l’interesse di quest’ultimo dovrebbe (rèctius, deve) considerarsi preminente rispetto all’opposto interesse dell’Amministrazione ad attendere che l’ordinanza del Magistrato trovi quantomeno conferma dinanzi al Tribunale, potendo prevalere l’attesa, viceversa, eccezionalmente, nei casi in cui l’esecuzione immediata delle ordinanze presupponga gravosi impegni amministrativi, di natura organizzativa e/o finanziaria.
In tal senso, ci limitiamo a prendere atto che, verosimilmente, l’eccezione suddetta venga posta in essere costantemente dall’Amministrazione e, di conseguenza, il Garante raccomanda, da un lato, che <<sia considerevolmente limitato l’esercizio dell’opposizione alle decisioni del magistrato di sorveglianza in accoglimento di reclami proposti ex articolo 35-bis o.p. e ancor più limitato il ricorso alla possibilità sospensiva dell’esecuzione delle relative ordinanze, in caso di opposizione>> e dall’altro, che venga formulata una <<nuova circolare [da parte del D.A.P.] allineata ai precetti dettati dalle sentenze della Corte costituzionale successive all’epoca in cui è stata emanata quella tuttora vigente>>. (v. pag. 45)
A cura di Stefano Colletti (Università di Pisa)
- Ci sia consentito utilizzare tale espressione nonostante il garante raccomandi <<di non definire mai il regime detentivo speciale quale «carcere duro» perché questo concetto implica in sé la possibilità che alla privazione della libertà – che è di per sé il contenuto della pena detentiva – possa essere aggiunto qualcos’altro a fini maggiormente punitivi o di deterrenza o di implicito incoraggiamento alla collaborazione. Fini che porrebbero l’istituto certamente al di fuori del perimetro costituzionale.>> (v. pag. 46)
- RENOLDI, Il regime differenziato dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, ontologia, problemi, prospettive (prima parte), § 4.1, in https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/2743-il-regime-differenziato-dellart-41-bis-dellordinamento-penitenziario-ontologia-problemi-prospettive-prima-parte-di-carlo-renoldi